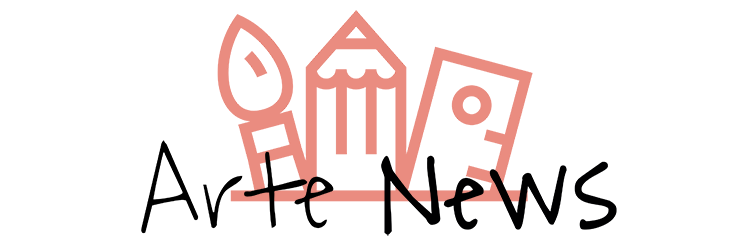Pieter Bruegel il Vecchio è uno dei più celebri esponenti della pittura seicentesca e la sua arte ha influenzato gli artisti per oltre un secolo
In un’epoca in cui i pittori prediligevano temi religiosi e mitologici, Pieter Bruegel il Vecchio rappresenta una figura unica, poiché nessun altro artista prima di lui aveva incentrato la sua opera sulla grandezza del paesaggio e sulla vita quotidiana dei contadini.
I suoi detrattori lo consideravano poco raffinato e lo soprannominarono con disprezzo “Bruegel il contadino”, tuttavia molti accademici, umanisti e facoltosi uomini d’affari apprezzavano e collezionavano le sue opere.
Pieter Bruegel, la vita e le opere dell’artista dei contadini
Le informazioni sulla sua vita sono scarse: nato a Breda, nel ducato di Brabante (attuale Belgio), tra il 1524 e il 1530, si formò come pittore ad Anversa. Dopo aver ottenuto il titolo di maestro, fece un viaggio in Italia. Al ritorno, si stabilì nuovamente ad Anversa, per poi trasferirsi nel 1562 a Bruxelles, dove si sposò e lavorò fino alla morte.
Non ci sono notizie precise sulla sua personalità o sulle sue credenze religiose e politiche, un aspetto rilevante in un periodo di grande agitazione nei Paesi Bassi per il diffondersi delle idee protestanti e i conflitti con Filippo II di Spagna.
Forse fu proprio questo clima teso a spingere Bruegel a rifugiarsi nell’evocazione del paesaggio e della semplice vita contadina.

Bruegel non ritraeva la vita campestre in situ, ma compose queste scene nel suo studio, basandosi sui numerosi bozzetti fatti durante i suoi viaggi in Italia e tra i paesini delle Fiandre.
Sebbene non siano una rappresentazione fedele della realtà, i suoi quadri illustrano il “teatro del mondo” che conosceva e cercava di dipingere in modo oggettivo e privo di sentimentalismi.
Le descrizioni di Bruegel dei rituali del mondo contadino, come il lavoro nei campi, la caccia, le feste, i giochi e le danze, sono vivide e indimenticabili. La sua opera offre una possibilità unica di osservare una cultura popolare oggi scomparsa.
Le opere di Pieter Bruegel il Vecchio hanno avuto un’influenza decisiva sull’evoluzione della pittura nei Paesi Bassi e oltre: attraverso i suoi figli, Pieter e Jan, Bruegel è diventato il capostipite di una dinastia di artisti che durò fino al Settecento.
Dei suoi lavori, ci sono pervenuti disegni, incisioni e oltre 40 dipinti, tra cui paesaggi e scene di vita rurale. La sua arte si distingue per la rappresentazione caricaturale, umoristica e a tratti grottesca della vita popolare.
La crescita artistica di Bruegel si può tracciare solo attraverso le sue opere, poiché si sa molto poco della sua vita. Le poche informazioni disponibili provengono dal “Libro della Pittura” del 1604, scritto dal fiammingo Karel van Mander, l’equivalente olandese di Vasari.
Secondo van Mander, Bruegel partì per l’Italia nel 1551, dove realizzò il suo primo dipinto nel 1553. Tornato in patria, divenne noto per le sue immagini satiriche, un tratto che lo caratterizzò e lo distinse dai modelli rinascimentali.
I temi cari a Pieter Bruegel il Vecchio includevano la vita nei campi, la religione, la superstizione e i complotti politici e sociali, spesso trattati con satira. Attraverso le sue pennellate, riuscì a tradurre su tela modi di dire popolari, espressioni colorite e il folclore contadino, inserendo episodi biblici o mitologici in vedute panoramiche della sua terra. Il suo approccio protestante alla religione, inusuale ed esemplare, venne ripreso da altri dopo di lui.
Bruegel fu apprendista di Pieter Coecke van Aelst, architetto, scultore e specialista in arazzi e vetrate a Bruxelles. Quando si trasferì ad Anversa, la sua carriera decollò dopo essere stato eletto alla Gilda di San Luca, una corporazione di pittori che gli garantì diverse commissioni.
Nel 1551 partì per un viaggio in Italia, visitando anche la Sicilia. Gli schizzi e le incisioni prodotte durante il soggiorno italiano divennero opere complete una volta tornato in patria, con dipinti dedicati ai panorami italiani, in particolare quelli montani, che lo influenzarono profondamente. Si fermò a lungo anche a Roma, come conferma il dipinto “Paesaggio con Cristo e gli Apostoli al mare di Tiberiade”.
Dal 1556, Bruegel predilesse soggetti moralizzanti, spesso ispirandosi alla maniera fantastica e grottesca di Hieronymus Bosch, ma con uno stile personale. Oltre ai paesaggi di campagna, si interessò alla figura umana e alle storie religiose e di vita quotidiana.
Riprendendo la tradizione formale e coloristica fiamminga, Pieter Bruegel il Vecchio rappresentava i suoi soggetti con dettagli minuziosi per restituire una composizione realistica che riflettesse la sua visione personale.
Nei suoi paesaggi raffigurava scene bibliche, parabole, personaggi mitologici, satire profane, scene di vita rurale e proverbi fiamminghi. Opere come “Lotta tra Carnevale e Quaresima” (1559), “Giochi di bambini” (1560) e “Margherita la pazza” (1562) sono allegoriche e satiriche.
La narrazione nei suoi dipinti partiva sempre dal paesaggio, che diventava vivo quando popolato da figure umane. Queste diventavano punti focali, spesso disposte in modo sparso nella composizione, raffigurate dall’alto o più grandi e ravvicinate. Questo modo singolare di comporre permise a Bruegel di distinguersi dai contemporanei, restituendo un ritratto veritiero della sua epoca.
Un esempio rappresentativo è il quadro “Proverbi fiamminghi”, dove persone e oggetti sono disposti in un paesaggio rurale fiammingo. In questa tela si possono individuare almeno 80 scene delle totali 120 che riproducono proverbi olandesi.
Bruegel inglobò in un unico dipinto i diversi modi di dire popolari, creando un “paese dei proverbi” dove ogni attività rispecchia un detto specifico. Il suo intento non era solo critico, ma anche un omaggio all’ironia e alla saggezza popolare.
Bruegel si concentrò molto sulla resa del movimento, rappresentando danze contadine e processioni religiose come in “La conversione di San Paolo”.
Questo dipinto, ambientato in montagna, rappresenta l’episodio tratto dagli Atti degli Apostoli. Le figure sono ritratte di spalle, con il fulcro dell’evento in secondo piano, creando una forte idea di verticalità grazie a elementi come alberi, rupi, lance e vessilli.
Nel suo ultimo periodo, Bruegel studiò maggiormente la figura umana in movimento, come nel dipinto “Parabola dei ciechi”. Qui rappresentò il movimento di sei uomini ciechi, di cui uno già a terra trascina gli altri.
Ispirato dalla parabola del cieco che guida un altro cieco, il dipinto utilizza la prospettiva per enfatizzare il movimento, con il villaggio di Sant-Anna-Pede sullo sfondo. Lo spettatore è invitato a seguire l’azione generale, mentre i dettagli delle singole figure rendono protagonisti diverse azioni come vagabondare, esitare e inciampare.